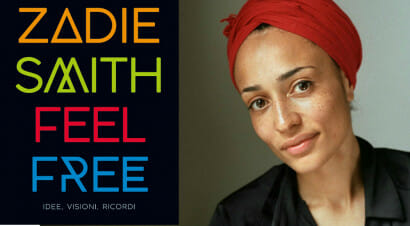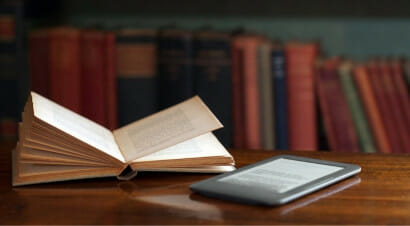In occasione della riedizione del suo esordio, “Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestra”, ilLibraio.it ha intervistato Claudia Dustantanti. Nella lunga conversazione si affrontano diversi temi: da New York, in cui il suo debutto è ambientato (e che oggi è alle prese con la pandemia, le proteste anti-razziste e le diseguaglianze sociali) all’impatto del virus sulla letteratura: “Ha indebolito l’approccio da personal essay, perché il senso di questa esperienza cambia costantemente, obliterando il suo recentissimo passato, e l’’io’ invecchia rapidissimamente”. La scrittrice riflette, tra le altre cose, sull’evoluzione del suo approccio alla scrittura, e si interroga su diverse questioni aperte: “Credo che sia un momento positivamente isterico per la narrativa… Mi rifiuto di concepire il cambiamento come declino, di fare cattive profezie sul romanzo”. Quanto al libro a cui sta lavorando, l’autrice de “La straniera” confida: “Scrivere significa stare a contatto con il problema, e stabilire un’intimità con l’ignoto”
A 10 anni dall’uscita, Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestra, il romanzo d’esordio di Claudia Durastanti (nella foto di Sara Luca Agutoli, ndr), pubblicato ai tempi da Marsilio, è tornato nelle librerie fisiche e digitali per la Nave di Teseo, con una nuova copertina e una playlist digitale gratuita associata.
L’autrice e traduttrice, che l’anno scorso ha fatto molto parlare con La Straniera (libro in cinquina al premio Strega e poi tradotto all’estero), si trovava a New York quando è stata dichiarata la pandemia. Era tornata negli Usa dopo aver lasciato Londra, città in cui ha vissuto alcuni anni, e dopo aver trascorso diversi mesi in Italia (dov’è rientrata da alcune settimane) per la promozione de La straniera.
Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestra – tornato in un momento storico a dir poco unico per l’intero pianeta – racconta una lunga adolescenza americana, che va dagli anni settanta ai primi anni duemila.

Durastanti, com’è stato ripensare al suo primo libro, in cui New York è protagonista, guardando da vicino la metropoli alle prese con il pesantissimo impatto dell’emergenza Covid-19, in cui le disuguaglianze si sono acuite e dove, proprio in queste ore, è stato deciso il coprifuoco per l’intensificarsi delle proteste delle proteste anti-razziste?
“Questa rilettura è coincisa con la definitiva risoluzione di una specie di patto romantico tra me e New York”.
Ci spieghi.
“Quando ho iniziato a scrivere Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestra ero ancora ossessionata dalla questione della legittimazione e della ‘cittadinanza’. Come si diventava americana, e come lo si dimostrava, soprattutto se eri in esilio? (Del resto tutta la mia prima vita italiana l’ho vissuta con questa esasperazione dell’esilio). E per me il vero possesso di una cultura coincideva con il possesso dei suoi miti. Tanto più avrei potuto dirmi parte del suo presente, quanto più andavo nel suo passato”.
E quale passato si è scelta?
“Quello del 1977 a New York, perché tra punk e disaffezione sociale mi sembrava una culla romantica per il disadattamento. Quella fede genuina in un posto mi manca, ma oggi so anche che si basava su premesse politiche e sociali fatte di grande sofferenza. Sono contenta di averla depositata in un libro prima che perdesse i contorni e mi diventasse inaccessibile. Era talmente appassionata, come ricerca, e fiduciosa nei propri mezzi narrativi, che a rileggerla non ho provato vergogna”.
Poi è tornata a New York.
“Sì, per mettere fine a un esilio, e sono successe due cose: la Nave di Teseo ha rimesso in circolo Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestra e io stavo chiudendo la traduzione de Il grande Gatsby per Garzanti. E dunque, per forza di cose, ho passato molti giorni a confrontarmi con gli archetipi americani, mentre fuori c’era la pandemia, arrivava una nave militare nell’Hudson, in teoria per dare sostegno nell’affrontare il Covid, questa immensa balena bianca che faceva pensare a Moby Dick ma in realtà era una mossa pubblicitaria. Lo scontro tra proiezione romantica, tra una vita infestata da letteratura musica e fantasmi, e la realtà materiale del momento, con nuovi problemi e nuovi contesti, è stato molto acuto”.

E cos’ha provocato?
“Ho scoperto che quella New York non mi mancava più, e mi sono sentita libera. È un grande sollievo disintegrare un amore attraverso i libri, o spegnere una luce verde. La sofferenza in cui ho sempre scritto di una certa America, essenzialmente urbana e con tanti dislivelli, la sofferenza della separazione, è stata soppiantata dalla consapevolezza che non stavo perdendo quel che credevo di perdere”.
Perché?
“Il mio rapporto con la città si basava su un fraintendimento storico. Non era più il posto per il disadattamento, nonostante rispetto a una città come Londra conservi ancora energie rudi, affettuosamente aggressive, e anche una maggiore capacità di scomporsi. L’America assunta nel suo complesso è un corpo esausto”.
A cosa si riferisce in particolare?
“È vecchio, non giovane. Pur avendo vissuto a lungo in Inghilterra, dove ho sentito tutto il peso di una certa accumulazione storica e l’usura di tanti parametri politici e sociali al punto da scegliere di andarmene, non ho mai assecondato quest’idea dell’America adolescente e inesperta, che scopre alcune cose per la prima volta e dunque rende alcuni fenomeni possibili. Proprio perché tanta della sua storia si basa su un’aggressività indomabile, oggi è inevitabile vederla e pensarla come una federazione di nazioni che si sono auto-sbranate. I primi giorni della pandemia, probabilmente alludendo al concetto di The center will not hold – popolare durante il periodo della contestazione culturale tra gli anni sessanta e settanta -, un concetto incorniciato pienamente da Joan Didion, un mio amico ha detto the grid will not hold, riferendosi proprio all’infrastruttura tecnologica e sociale di New York. La sua idea era che la città non fosse strutturata per contenere l’epidemia, che il suo equilibrio, basato su scarafaggi che non muoiono mai e improbabili teorie dell’adattamento – se sopravvivi ai batteri della subway sopravvivi a qualsiasi cosa – si sarebbe rivelato falso. Finalmente quell motto, if you can make it here you can make it here you can make it anywhere, si sarebbe rivelato in tutta la sua stucchevolezza: ci sono persone che don’t make it there e don’t make it nowhere in America“.
E dalla pandemia veniamo alle proteste e alle manifestazioni di questi giorni negli Usa.
“La realtà è che New York, come altri capitali e grossi centri urbani in cui il conflitto forse si esaspera prima, non è più strutturata per contenere un sistema ingiusto. Non è l’eccezione a essere incontenibile, è lo stato di cose a esserlo. Non è il nuovo a far collassare un sistema, ma il vecchio. Non l’imprevedibilità del virus e la sua magnitudo colossale, ma quello che una società ha ormai tantissima voglia e fame di espellere da sé stessa: ecco perché le proteste in seguito all’omicidio di George Floyd – non dobbiamo chiamarla morte, ma omicidio – si sono diffuse con questa forza e intensità. Certe idee che vengono associate a New York, come città dotata di anticorpi potentissimi, sono in realtà molto fragili: questo semmai vale per una città come Roma, che è una città iper-batterica e contenuta. Ma se sei portuale, porosa ed esanime, qualcosa poi ti penetra e ti affonda. E dunque la distanza tra una città che sentivo magica e eterna, e di cui ho scritto nel mio esordio, e quella in cui ho abitato di recente e a cui tornerò, si è divaricata molto. Ma penso che sia un fenomeno positivo: una società si giudica anche per il suo moto inerziale, e in questi anni il moto degli US mi pare più verso la ricerca di nuove forme di giustizia sociale che un soccombere sempre alla stessa violenza. È positivo anche sul piano della letteratura, ovviamente”.
Perché?
“Forse adesso è possibile scrivere storie nuove e diverse. E ci saranno nuove metafore, e anche nuovi modi concreti di pensare: dire che negli Stati Uniti non si sono mai rimarginate le ferite della guerra civile, dello schiavismo e della segregazione non mi pare del tutto corretto. L’aspetto inquietante è il modo in cui certe ferite si sono chiuse e rimarginate, creando ammassi di pelle, cicatrici e ispessimenti che sono persino peggiori di una ferita che sanguina. Quando qualcosa sanguina si interviene, non lo si dimentica, si sta dentro il flusso”.
E invece?
“Così, molte cose si sono date per scontate e pacificate, e poi su vecchie ferite e tagli c’è stata pure l’oscenità di apportare nuove ferite, che sono contemporanee, e legate al contemporaneo: penso al sistema brutale degli sfratti che affliggono la comunità afroamericana (vale la pena leggere il bellissimo saggio Evicted, in questo senso: non é che oggi non si affitta ai neri, si affitta volutamente ai neri a prezzi esorbitanti che garantiscono un andamento isterico e dinamico del mercato immobiliare, alzando sempre di più la cifra in ballo e garantendosi inquilini facilmente sfrattabili) la questione del capitalismo carcerario e dell’industria dietro il rastrellamento di giovani uomini neri che vengono condannati alla reclusione per le questioni più effimere. Si tratta di un abuso reiterato ma, a suo modo, sempre perversamente creativo, perché è incessante questa ricerca di nuove forme per sottomettere le minoranze. Per questo sento il bisogno di tornare ai classici della black culture solo fino a un certo punto, penso invece ai testi vivi adesso. La lotta e il pensiero associato alla lotta, dunque, devono essere altrettanto agili. Black Lives Matter è interessante proprio per questo: perché spazza via tanta retorica legata al movimento per i diritti civili, che nel corso del tempo si è fatta addomesticata, così come si è voluto addomesticare il pensiero di Martin Luther King, nel tentativo di distinguere le proteste giuste da quelle ingiuste. Ma in questo momento qualsiasi criterio che fa separazione tra i modi e le forme della lotta è fuorviante”.
Con quali effetti, per chi, come lei, scrive?
“Tutto questo offre infinite possibilità di ripensamento. E allora New York oggi è questo per me: il posto ripensato”.
Può interessarti anche
In riferimento al suo debutto ha scritto: “Grazie a questo libro ho conosciuto alcune delle persone più importanti della mia vita, e sarà sempre il romanzo dei miei vent’anni”. Com’è cambiato il suo approccio alla scrittura da allora? E cosa, invece, ha conservato?
“Oggi scrivo pensando sempre di meno a una comunità di persone che mi somiglia, o meglio: scrivo cercando di stabilire un’intimità con l’ignoto. Un esordio è anche un romanzo di posizionamento, spudoratamente affermativo, pieno di sicurezze; la scrittura poi si fa progressivamente orfana. Meno lucida e assassina in un certo senso, o mi pare che mi sia successo questo. Traggo molti vantaggi dalla confusione oggi”.
E in passato, invece?
“Quando è uscito il mio primo romanzo una mia amica mi ha fatto notare che c’erano tantissimi vestiti dentro, e descrizioni di modi di vestirsi. Era la famosa ‘divisa’, qualcosa verso cui nutrivo una fascinazione antropologica: io non mi sono iscritta a Teorie e pratiche dell’antropologia per capire come funzionava la parentela nelle isole Trobiand, o perché volevo sapere tutto sulle adolescenti samoane, ma perché volevo capire perché i punk si mettevano le spille da balia nelle orecchie. La mia amica diceva che manco nei libri di Bret Easton Ellis c’erano tutti quei vestiti, e aveva ragione! Poi qualche tempo fa ho letto Caro Michele di Natalia Ginzburg, e quando mi sono accorta dell’allusione continua e ostinata ai vestiti dei personaggi ho sorriso”.
Può interessarti anche
Cos’ha pensato?
“Forse nella mia scrittura oggi si sente la differenza tra queste due tendenze, la smania per la precisione, per l’identificazione di un personaggio, che vive una libertà limitata, e invece una certa naturalezza e anche distrazione nel permettergli di essere quello che vuole. Oggi nei personaggi che scrivo c’è un bisogno meno istintivo di dirsi e sentirsi importanti. Dell’esordio mi interessa ancora una certa spudoratezza nel diritto a immaginarsi qualcosa di diverso da sé, e non a caso citavo il problematico Ellis prima. Le sue argomentazioni in White sono mal formulate e miopi, ma i suoi occasionali barlumi sui ruoli possibili della fiction, non a caso, sono stati oggetto di una riflessione di Zadie Smith sulla letteratura che non ha paura a farsi di nuovo romanzesca, dopo essere stata tanto testimoniale”.
Può interessarti anche
Che riflessioni ha fatto, a questo proposito?
“Quando scrivo un romanzo non assecondo teorie o mi propongo di far parte di una causa, sarebbe disastroso, ma è innegabile stare dentro a un flusso di cambiamenti: a vent’anni facevo parte di una cultura in cui era ancora possibile che una parola a forte connotazione razziale venisse utilizzata con un piglio ironico, era un fatto straordinariamente poco problematizzato, annoverato anche nei diritti di una lingua sporca, nel diritto a cantare certi testi hip-hop misogini e auto-deprecanti senza paura. È una fase conclusa, che suonerebbe morta in un testo oggi, e che non ho alcun interesse a recuperare. Mi affascina invece l’idea di scovare un’altra lingua, più libera e allo stesso tempo anche gentile, incisiva e carica di piacere, ma che contiene sistemi di senso e vite e possibilità di vite senza essere esclusiva. Mi interessa una scrittura che non confonde l’empatia con l’appropriazione, un uso poetico e intelligente del silenzio e del limite, e del de-centralizzarsi. L’io periferico, e allo stesso tempo una terza persona molto partecipata”.
Ritrova in parte queste sue fascinazioni nella letteratura contemporanea?
“Credo che sia un momento positivamente isterico per la narrativa, se si trova il coraggio artistico di de-zavorrare la propria scrittura dalla teoria, tentando invece un attacco propriamente poetico e stilistico, che nasce dopo anni di lento assorbimento e studio sulle cose che fanno il mondo e sono il mondo. Ho molte aspettative, innanzitutto attorno a me, e poi dentro di me, chiaramente. Mi rifiuto di concepire il cambiamento come declino, di fare cattive profezie sul romanzo”.
Può interessarti anche
Il virus sta avendo un impatto pesante, a ogni livello, sull’intera filiera del libro. Dai lavoratori della case editrici ai librai, dai traduttori agli stampatori, tutti sono colpiti. Ci si interroga anche su come (e se) scrittrici e scrittori di narrativa faranno in qualche modo entrare (o meno) il virus nelle loro prossime opere: qual è la sua posizione a riguardo?
“Ho una posizione rudimentale sui testi che funzionano come spugne, e poi vengono strizzati da una mano consapevole. Credo sia inevitabile che la scrittura imbarchi acqua in questa fase, tanto per restare dentro quest’immagine goffa, ma credo anche in una grande consapevolezza autoriale che poi asciuga tutto. Io non penso che autrici e autori siano davvero profondamente incuriositi dalle possibilità narrative di questo virus e del collasso sistemico attorno, mi pare di registrare più un imbarazzo e un desiderio di allontanarsene, non per mancato impegno”.
E perché?
“Si tratta di una letteratura esausta in partenza, talmente pervasiva da non lasciare spazio a soluzioni autonome in termini di forma, stile, e idea. La letteratura del virus già si presenta con dei generi prestabiliti: la memorialistica, la non fiction ibrida, o la distopia rivisitata. E non è mai un buon segno quando un fenomeno detta già la sua forma, che sia perché il mercato ha fame di determinati generi o perché è un dovere scrivere di qualcosa. Quando un evento di proporzioni colossali come il virus diventa un evento a cui tutti sono soggetti, pur con effetti e conseguenze diverse in base alla propria vita, che fine fa il valore della testimonianza personale? In qualche modo il virus ha reso impraticabile la strada del ‘Ho scritto un pezzo su…’, ‘Ho vissuto questo e ne scrivo…’, o quantomeno ha indebolito molto questo approccio da personal essay, perché il senso di questa esperienza cambia costantemente, obliterando il suo recentissimo passato, e l’’io’ invecchia rapidissimamente in questa fase”.
Può interessarti anche
A proposito, ha iniziato a lavorare a un nuovo libro?
“Raccolgo indizi da un po’. La scorsa estate ho fatto un tour in Basilicata per presentare La Straniera con Giorgia Tolfo ed Eloisa Franchi, due amiche e colleghe che vengono da discipline diverse dalle mie e ho sentito che tutte le mie energie e interessi gravitavano attorno al sud, o alla demistificazione di una certa idea di sud. Vedere un posto familiare insieme a loro, assistere al collasso di certe aspettative o alla gioia di una scoperta è stato positivo per me, e anche se il nuovo romanzo che ho iniziato a scrivere vive solo in parte di questo, sicuramente qualcosa è rimasto. Qualche mese fa stavo passeggiando nel mio quartiere a Brooklyn e in pieno lockdown ogni pianta o albero mi sembravano bellissimi e osceni, uno spettacolo della atrocità in senso ballardiano: come ha fatto la vita vegetale a diventare spaventosa, il dataismo di tutti i nostri giorni, il senso di una frontiera che si è persa e spostata ad altre latitudini, il lessico del riscaldamento globale, dell’estrazione mineraria, il reciproco addomesticamento con specie irriconoscibili e nuove, una prima persona plurale femminile, tutte le cose a cui ho dedicato un interesse spontaneo negli ultimi anni sono finalmente diventate un problema per me. Non su come sto al mondo, ma su come lo immagino e scrivo”.
E dunque cosa significa per lei oggi scrivere un nuovo romanzo?
“Proprio questo. Stare a contatto con il problema, e stabilire un’intimità con l’ignoto”.
Fotografia header: Claudia Durastanti (nella foto di Sara Luca Agutoli, ndr)